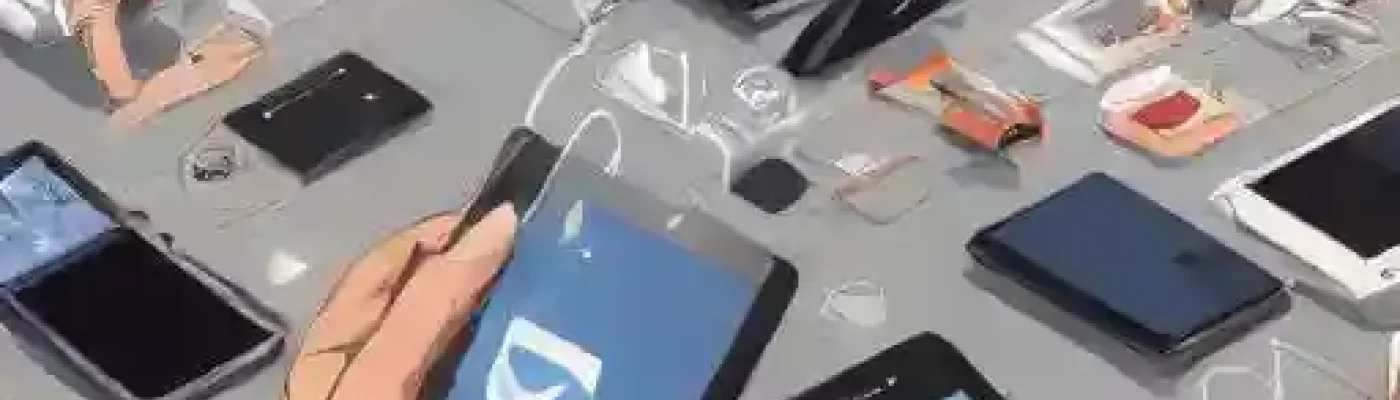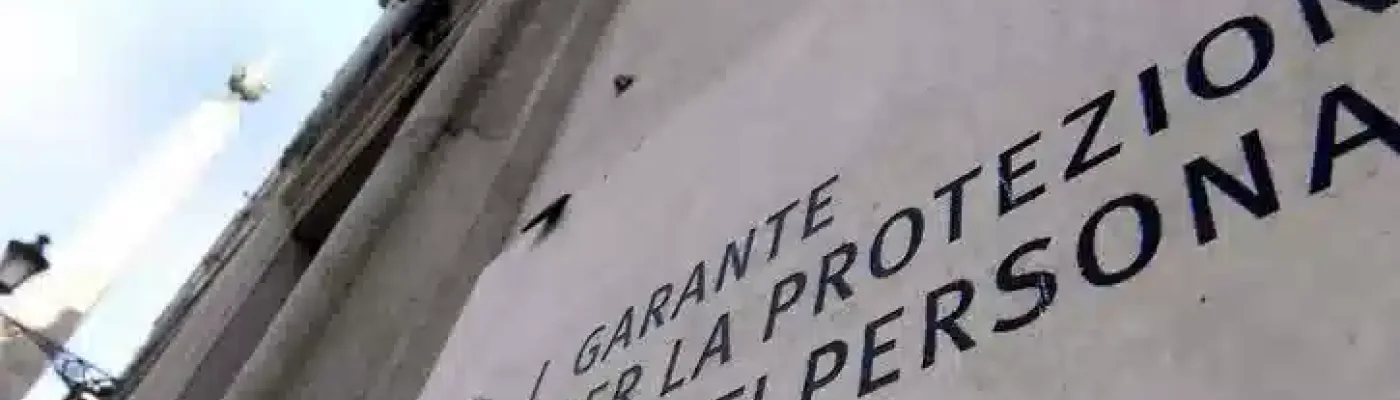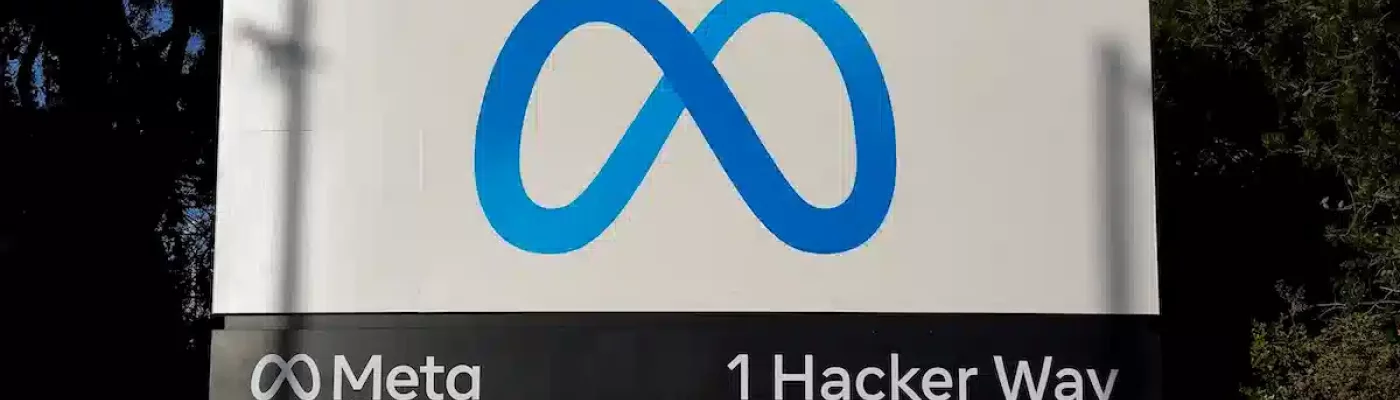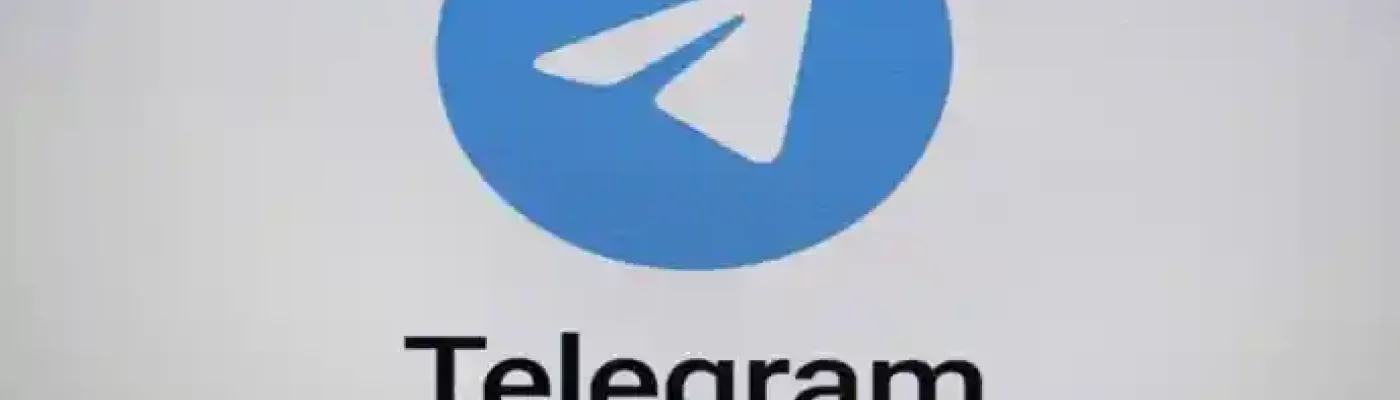Pillole
L'Alta Corte dell'Unione Europea ha emesso una sentenza che limita l'uso dei dati personali degli utenti da parte di Meta e altre piattaforme social per scopi pubblicitari. La decisione, in linea con un parere precedente di un consulente della corte, impone restrizioni sulla durata della conservazione delle informazioni personali per il targeting degli annunci.
La sentenza fa riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE, istituito nel 2018. In particolare, si basa sul Recital 65 del GDPR, che stabilisce il "diritto all'oblio" e il diritto alla rettifica e cancellazione dei dati personali. La mancata conformità al GDPR potrebbe comportare sanzioni fino al 4% del fatturato annuo globale, cifra che per colossi come Meta potrebbe ammontare a miliardi di euro.
Guardare avanti, si dice. Guardare fisso, invece, la propria mano che sostiene un apparecchietto nero con schermo, detto smartphone. Consultare, sbirciare, controllare, scrollare, ascoltare, pagare, scrivere, parlare, filmare… Al ristorante, per strada, in chiesa, nel passeggino, al cinema, in arrampicata, al supermercato, in auto, in classe, in ospedale, sul bus, sul water, a letto, in bici, al lavoro, ai mari e ai monti… in tasca, in mano. A testa bassa.
Paesaggio umano smisuratamente social. Ognuno di noi al guinzaglio del proprio smartphone. Ad ogni latitudine, più o meno. Ad ogni età, neonato e pensionato, per ogni sesso. Super intersezionale. La psichiatria, che ha il naso fino, ha inventato il problematic smartphone use (PSU) Ma quale problematic? Obvious smartphone use. Non è un gingillo, è una Lampada di Aladino dai mille favori. È un essere più che uno strumento tecnico. Non sono un filosofo e torno a incantarmi con questo congegno luccicante che ci ha catturati, dionisiacamente “sussunti” direbbero gli intenditori. Se fossi nato vent’anni fa non mi stupirebbe toccar quotidianamente con mano la nostra universale dedizione all’Angelo Custode che ogni giorno ci accompagna e ci nutre, mi sarebbe risuonato perfettamente naturale, oggettivo, da sempre. Una felice evoluzione dell’umanità.
Di chi è figlia questa alchimia universale? Del capitalismo digitale, di quello cognitivo, di quello zombi? Di un neo colonialismo psichico? Di una fantomatica tecnodittatura? Di un dio cattivo, o anche buonino, che escogita una nuova religione? Di quei cinque o sei giovanottoni diventati paperon de’ paperoni giocando con il web e inventando questo e quello? Di un presente a capitalismo morto, che sarebbe ancora peggio del capitalismo vivo? Di me boccalone e dei miei simili che ci facciamo accalappiare da questa sbalorditiva pietra filosofale rettangolare?
Lo sostiene uno studio dell'Università della California, che rivela come le TV LG e Samsung registrano i contenuti visualizzati e li usano per profilare gli utenti.
Molti conosceranno Shazam, l'applicazione che è in grado di riconoscere una canzone "ascoltando" pochi secondi di essa. Qualcosa del genere avviene con le Smart TV e i programmi televisivi, solo che il funzionamento è automatico e prescinde dalla volontà dell'utente.
A svelarlo è uno studio dell'Università della California, che ha analizzato i televisori di LG e Samsung nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Il 176° Mercoledì di Nexa si terrà mercoledì 9 ottobre, alle ore 17.30, con un incontro dal titolo "An anti-fascist approach to AI means decomputing".
Ospite: Dan McQuillan (Goldsmiths, University of London), autore del libro Resisting AI. An Anti-fascist Approach to Artificial Intelligence.
Tutte le informazioni per partecipare sono sul sito del Centro Nexa for Internet Societty
Leggi una recensione del libro
"AI’s apparatus of computation and social relations produces a nested set of inevitable harms, from states of exception to environmental degradation. A common thread running through its mathematical operations, its c2ontemporary applications and its accompanying ideologies is the reemergence of eugenics and authoritarian social logics.
In this talk I will argue for an anti-fascist approach to AI that aims for alternative technopolitical outcomes. I will suggest a strategy of decomputing which combines degrowth and decolonialism in order to delegitimise AI’s extractivism and its use as a diversion from the structural failures of the status quo. In practice, this would consist of forms of action that reject hyperscale machinery hurtful to the commonality, and instead attempt to transform collective subjectivities and technical arrangements at the same time."
AlphaGo è un’Intelligenza artificiale creata dalla società DeepMind, oggi controllata da Google, per battere gli esseri umani al gioco orientale del Go. Nel 2016 ha sconfitto il campione mondiale con una mossa ritenuta “sbagliata”, spingendo diversi osservatori a parlare di intelligenza quasi magica. Una visione “tecnoentusiasta” che agita l’imperscrutabile ma dimostra di ignorare la statistica. E non solo.
La tecnologia odierna si presenta, software o hardware che sia, sotto forma di “scatole oscure” che i produttori confezionano in maniera da renderci impossibile comprenderla, studiarla e -soprattutto- modificarla. Questa impossibilità si traduce spesso in una forte sensazione di alienazione che fa sì che più di una persona si trovi a disagio.
Secondo il filosofo Gilbert Simondon, l’alienazione tecnica cresce al crescere del divario tra cultura e tecnica. Questo divario fa sì che la tecnica venga vissuta come pericolosa dai tecnofobici, ossia da coloro che pensano che la tecnica sia inferiore alla vera cultura (quella umanistica “classica”), e come magica dai tecnoentusiasti, ossia da coloro che pensano che il sapere tecnico sia un sapere riservato a pochi eletti.
Alla luce dell'annuncio del gruppo GEDI, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha deciso di seguire la situazione molto da vicino.
Nessuna indagine. Nessun approfondimento. Ma un faro acceso per capire l’impatto – in termini di protezione dei dati personali – dell’appena annunciato accordo di “partnership strategica” siglato tra OpenAI e il Gruppo Gedi. L’apertura dei contenuti pubblicati sulle edizioni online dei quotidiani La Repubblica e La Stampa (e gli altri che fanno parte del gruppo editoriale di proprietà della holding Exor) all’addestramento di ChatGPT e al prototipo del motore di ricerca SearchGPT è finita immediatamente sotto l’attenzione del Garante Privacy. Quasi a voler dire: “Uomo avvisato, mezzo salvato”.
La Data Protection Commission (DPC), l’autorità irlandese che si occupa di privacy e che agisce in materia per conto dell’Unione Europea, ha multato Meta per 91 milioni di euro per non aver tutelato in maniera adeguata le password dei suoi utenti.
Meta è la società statunitense che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp e la sanzione è stata stabilita in seguito a indagini cominciate nell’aprile del 2019, quando Meta aveva avvisato l’ente irlandese di aver inavvertitamente conservato le password nei suoi sistemi interni senza che fossero criptate: è una violazione del Regolamento generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati (GDPR), la legge europea in vigore dal maggio del 2018 e pensata per rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini e dei residenti dell’Unione Europea.
Nell'ambito delle azioni del PNRR anche per l'anno scolastico 2024/2025 C.I.R.C.E. ha organizzato dei corsi di Pedagogia Hacker su misura per docenti delle scuole primarie e secondarie. Scopri i 3 cicli: date, orari e contenuti.
Ogni corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie o primarie, sia di ruolo che precari/e ed è gratuito. Puoi scegliere di partecipare a uno dei corsi o a tutti e tre. Il primo corso è propedeutico ai successivi. Per ogni corso seguito verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Segui questo link per vedere la registrazione della presentazione
Sul sito di CIRCE puoi leggere titoli, orari e panoramica dei corsi
L’app di messaggistica Telegram consegnerà alle autorità giudiziarie gli indirizzi IP delle connessioni per risalire all’identità delle persone e i numeri di telefono degli utenti nel caso di procedimenti legali nei loro confronti. Lo ha annunciato il fondatore di Telegram, Pavel Durov, in un post sul proprio canale certificando la capitolazione di fronte alle pressioni delle autorità francesi.
Durov, cittadino russo ma con cittadinanza francese ed emiratina era stato arrestatolo scorso 24 agosto al suo arrivo a Parigi. Accusato, in quanto fondatore insieme al fratello e amministratore delegato di Telegram, di complicità per i traffici illegale, ovvero distribuzione di materiale pedopornografico, droghe illegali e software di hacking, che si appoggiano alla piattaforma. Durov è stato poi rimesso in libertà sotto cauzione con il divieto di lasciare il territorio francese e l’obbligo di presentarsi due volte alla settimana alla polizia. Un precedente che molto aveva fatto discutere.
Nella prima parte della puntata analizziamo gli aspetti tecnici dell'attacco terroristico israeliano che ha utilizzato i cercapersone (e non solo) come bombe diffuse nella società. Cosa sono i cercapersone, in quali casi sono usati, come è avvenuto l'attacco...
Nella seconda parte parliamo di industrie dei microprocessori. Ancora una volta si parla di una acquisizione tra Qualcomm e Intel. Non è detto che avvenga, ma sicuramente è tra le possibilità concrete, anche per reagire ad uno strapotere di Nvidia. Infatti Nvidia ha un ruolo di primo piano nell'industria delle GPU, industria di fondamentale importanza nello sviluppo della cosiddetta Intelligenza Artificiale. Le sue azioni sono salite di botto, cosa che ha portato alcuni giornali a titolare articoli che ci dicono che ora la Nvidia ha problemi di prepensionamento: i suoi dipendenti hanno ricevuto azioni, quindi ora sono ricchi, quindi non vogliono più lavorare. Una spiegazione non del tutto convincente, visto che le aziende, soprattutto nel settore tecnologiche, pagano in azioni (o simili prodotti) proprio per ancorare chi lavora all'azienda.