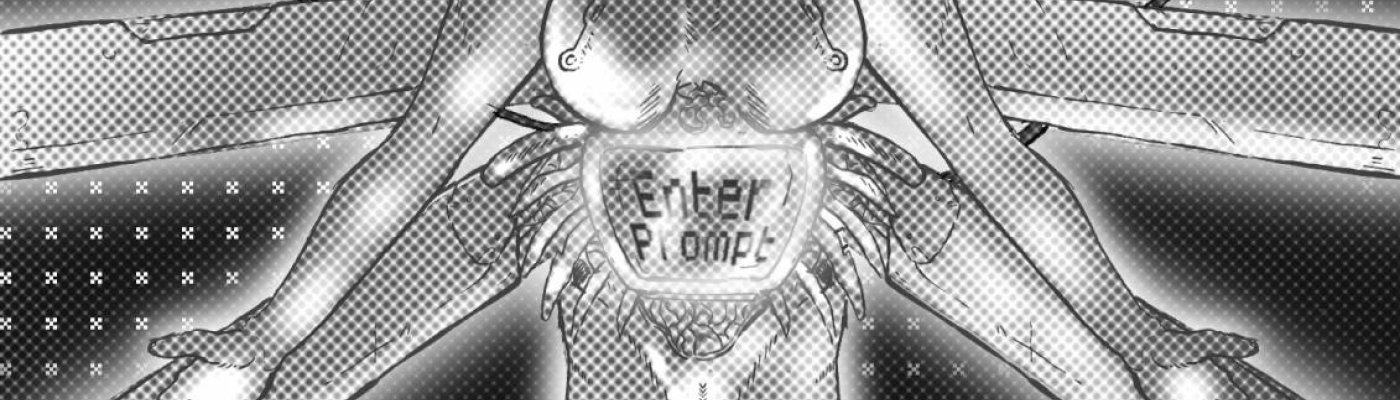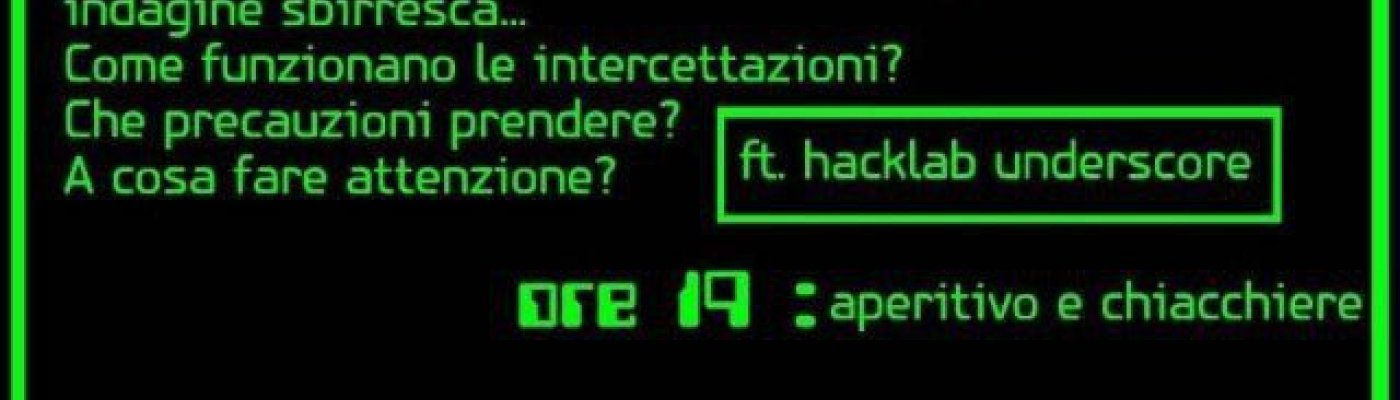Pillole
Come funziona autistici.org? E soprattutto, perché funziona in un determinato modo?
Secondo volume del “come facciamo le cose e soprattutto perché”
Lo scopo di questo documento è esaminare in dettaglio sia l’architettura tecnica che sta dietro ad Autistici/Inventati dal 2019, sia le scelte che l’hanno determinata. Allo stesso tempo, oltre che la descrizione di uno stato di fatto, questa è anche una storia, un esempio crediamo positivo di una complessa transizione …
Abbiamo cercato di realizzare un percorso sostenibile per le persone coinvolte, un aspetto fondamentale per un progetto di volontariato, provando ad introdurre alcuni selezionati concetti e alcune best practices provenienti dal mondo dell’industria del software, senza trasformarci in un contesto necessariamente di e per professionisti.
Leggi l'introduzione online
e scarica il documento in vari formati
I dispositivi elettronici, inclusi i telefoni cellulari e i tablet, saranno banditi dalle aule scolastiche in Olanda. Lo ha annunciato il governo.
L'iniziativa, introdotta in collaborazione con gli istituti, entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno. Lo riporta la Bbc.
"Anche se i telefoni cellulari sono quasi intrecciati con le nostre vite, non appartengono alla classe", ha detto il ministro dell'Istruzione Robbert Dijkgraaf, sottolineando che "gli studenti devono essere in grado di concentrarsi e di avere tutte le opportunità per imparare bene". Mentre invece "sappiamo dalla ricerca scientifica che i telefoni cellulari interrompono questo processo".
Il deputato francese Philippe Latombe ha intentato una battaglia legale control il Data privacy framework, il nuovo patto Usa-Ue per lo scambio di dati su base transatlantica.
Latombe, membro del parlamento in patria, chiede di sospendere subito l’accordo e ha depositato la richiesta alla Corte di Giustizia Ue, aprendo la stura ad una valanga di ricorsi contro il nuovo accordo per la trasmissione dati fra le due sponde dell’Atlantico.
Durante il Festival della Letteratura di Mantova C.I.R.C.E. è stata invitata a partecipare con laboratori e incontri.
Nel sito del festival c'è un articolo
che racconta come sono andati i laboratori tenuti da Agnese Trocchi e Carlo Milani. Spoiler: a quanto pare bene!
I laboratori sono stati sul tema "Demoni, Angeli e Social: Pedagogia Hacker"
Se invece volete (ri)vedere la "lavagna" di presentazione del libro "Tecnologie Conviviali" di Carlo Milani, tenuta dall'autore stesso, potete farlo: c'è una registrazione video.
Il Centro sociale occupato e autogestito “Angelina Cartella” di Reggio Calabria ha ospitato fino a domenica 10 settembre l’Hackmeeting 2023, l’incontro annuale che si tiene dal 1998 ed è dedicato alle controculture digitali italiane, “quelle comunità – si legge nell’indizione dell’appuntamento – che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all’interno della nostra società. Ma non solo, molto di più.
l’hackit è solo per hackers, ovvero per chi vuole gestire la propria vita come preferisce e sa s/battersi per farlo. Anche se non ha mai visto un computer in vita sua”.
Il programma una quattro giorni di seminari, giochi, dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo, per analizzare “assieme le tecnologie che utilizziamo quotidianamente, come cambiano e che stravolgimenti inducono sulle nostre vite reali e virtuali, quale ruolo possiamo rivestire nell’indirizzare questo cambiamento per liberarlo dal controllo di chi vuole monopolizzarne lo sviluppo, sgretolando i tessuti sociali e relegandoci in spazi virtuali sempre più stretti.
Radio Onda d'Urto ha intervistato alcuni partecipanti
Ascolta l'audio sul sito della radio
Cosa ci insegna la storia di ELIZA, il primo chatbot che sembrava conversare come un umano. A partire da come il suo creatore divenne un critico feroce della perdita di autonomia dell’umano.
Tra i tanti ruoli che ChatGPT ha rapidamente iniziato ad assumere nelle vite dei milioni di utenti che lo utilizzano su base quasi quotidiana, ce n’è uno probabilmente inatteso. Per molti, il sistema di OpenAI con cui è possibile conversare su ogni argomento, e spesso in maniera convincente, è diventato un amico, un confidente. Addirittura uno psicologo. Una modalità non prevista (almeno esplicitamente) da OpenAI, ma scelta da un numero non trascurabile di utenti, che si relazionano a ChatGPT come se davvero fosse un analista. Per impedire un utilizzo giudicato (per ragioni che vedremo meglio più avanti) improprio e pericoloso, OpenAI impedisce al suo sistema di intelligenza artificiale generativa di offrire aiuto psicologico, che infatti di fronte a richieste di questo tipo si limita a fornire materiale utile da consultare. Ciò però non ha fermato gli “utenti-pazienti” che, su Reddit, si scambiano trucchi e tecniche per sbloccare ChatGPT affinché fornisca loro consigli psicologici.
Joseph Weizenbaum e il suo chatbot ELIZA
Un risvolto che potrebbe sorprendere molti. Uno dei pochi che sicuramente non si sarebbe sorpreso e che avrebbe avuto moltissimo da dire sull’argomento è Joseph Weizenbaum, scienziato informatico e docente al MIT di Boston, scomparso nel 2008. Colui che già parecchi decenni prima della sua morte aveva preconizzato – o meglio, affrontato e approfondito in prima persona – molti degli aspetti che portano le persone a relazionarsi in maniera intima con le macchine e le cause di questo comportamento.
L’uso intensivo e precoce degli smartphone nei ragazzini non favorisce l’apprendimento, anzi, riduce le performance scolastiche di una parte consistente della popolazione studentesca. E ora, una ricerca di Milano-Bicocca e SUPSI sui dati INVALSI lo conferma, andando oltre le semplici correlazioni.
La ricerca dal titolo“Earlier smartphone acquisition negatively impacts language proficiency, but only for heavy media users. Results from a longitudinal quasi-experimental study”, condotta da Tiziano Gerosa, ricercatore della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e Marco Gui, direttore del Centro Benessere Digitale di Milano-Bicocca (dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale) ha testato le principali ipotesi teoriche sul ruolo dello smartphone nei processi di apprendimento, sia quelle che ipotizzano benefici sia quelle che si attendono impatti negativi.
Nell'ultima puntata dell'estate di DataKnightmare, Vannini prende spunto da un paper per porre alcune domande e diversi avvertimenti.
Il paper si pone due domande semplici.
Se l'uso di chat gpt possa veramente migliorare la produttività e se l'uso di chat gpt abbia effetti diversi su lavoratori meno schillati che su lavoratori più schillati.
Le risposte sono chiare.
Con chat gpt il livello medio dei testi migliora e i tempi di produzione si abbassano, quindi siamo autorizzati a dire che la produttività cresce. Inoltre con chat gpt la differenza fra le capacità dei singoli viene fortemente ridotta.
Pur prendendo per buono il risultato del paper, le criticità sono molte.
Tra e altre: avere addestrato le cosiddette intelligenze artificiali in prevalenza su contenuti disponibili in internet, con le virgolette, significa che le intelligenze artificiali sanno scrivere come un marchettaro a cottimo, Perché quelli sono i contenuti prevalenti in internet, marketing, report aziendali senza anima e comunicazione funzionale.
Ieri abbiamo insegnato alle macchine come scrivono gli esseri umani usando come esempio quando gli esseri umani scrivono come macchine.
Il pericolo è che i vari chat gpt diventino il termine di paragone, per cui da domani gli esseri umani dovranno scrivere come macchine per non perdere la competizione contro macchine che scrivono come esseri umani che scrivono come macchine.
Ascolta la puntata e buon ascolto.
il 23 e 24 settembre 2023 due giorni sulla sicurezza dei nostri dispositivi informatici.
Il 23 un membro dell'Hacklab Underscore di Torino verrà a raccontarci cosa hanno scoperto su come sono state portate avanti le indagini di un'operazione contro gli anarchici. Il giorno dopo, il 24 ci sarà un laboratorio più pratico per cercare di demistificare un po' il mondo dell'informatica. Sperimenteremo concretamente come funziona il passaggio dei dati da un dispositivo all'altro, e cercheremo di capire come e in che modo potrebbe avere senso configurare il nostro dispositivo a seconda del livello di sicurezza che vogliamo tenere. Chi vuole può portare il proprio dispositivo( computer o smartphone) e una chiavetta.
L'abbandono dei dispositivi tecnologici suonava come una frase strana una decina d'anni fa, oggi sembra praticamente impossibile e siamo nella condizione di mettere quasi ogni attimo della nostra vita nelle mani delle grandi aziende tecnologiche. Dalle perquisizioni, alle intercettazioni telefoniche, ai metadati che vengono raccolti dai siti e le Big Tech GAFAM, tutti modi di intrufolarsi nelle nostre vite e rapinare le nostre informazioni. Un giro di soldi enorme, certo, ma non solo: il furto di queste informazioni viene poi a piacimento usata dalla polizia contro di noi per umiliarci, reprimerci, e fermare le nostre lotte. In particolare poi se sei o vieni considerato un nemico dello Stato. Quali informazioni vengono usate durante le indagini? Come vengono raccolte? Come proteggere sè stessi, le persone intorno a te e i nostri percorsi collettivi?
Leggi tutte le informazioni sul sito della Villa Occupata di Milano
"Apriamo la trasmissione con una notizia che unisce i nostri principali interessi: "hacker" filorussi fermano dei treni in Polonia. Da quanto si capisce, la tecnica usata è estremamente vecchia, nota, utilizzabile da chiunque con spese modestissime.
A proposito di infrastrutture critiche, andiamo a guardare e commentare la conferma, da parte del Governo, del memorandum con KKR. Di fatto, una cessione di infrastrutture critiche.
Tornando dalle nostre parti, dedichiamo un po' di spazio a rispondere alla campagna di stampa che il Messaggero sta facendo contro i progetti di tram di Roma. Andiamo quindi a guardare quali sono effettivamente gli impatti, gli usi, i vantaggi del tram, capiamo perché non è banalmente rimpiazzabile con le metropolitane o con i bus elettrici e proviamo ad inquadrare questa tecnologia all'interno di un sistema generale di trasporto pubblico. Proviamo anche a rispondere alle domande di un ascoltatore che ci chiama per chiederci un'opinione sul tema delle vibrazioni, degli edifici storici, e delle dimensioni dei tram."
Ascolta la puntata del 5/09/2023 sul sito di Radio Onda Rossa