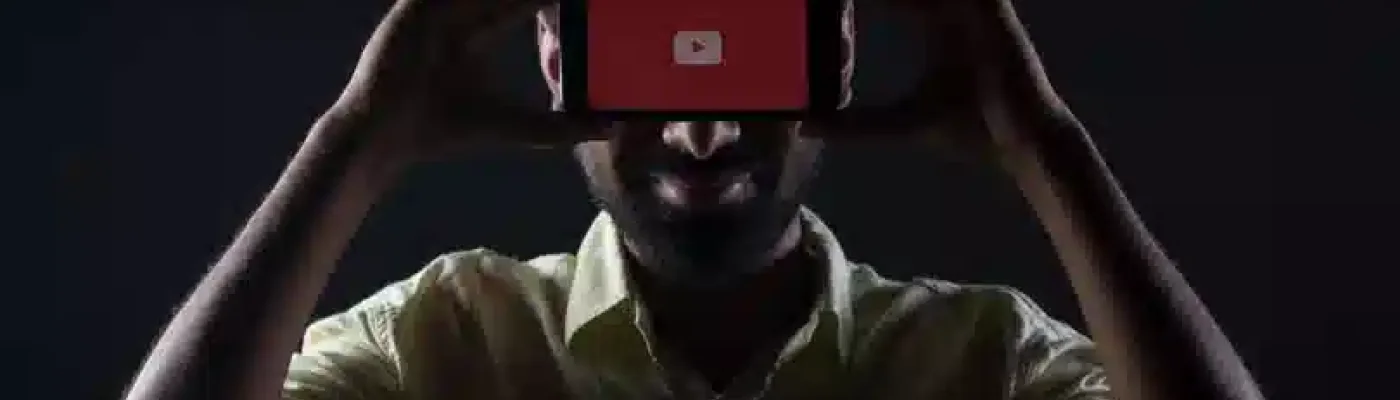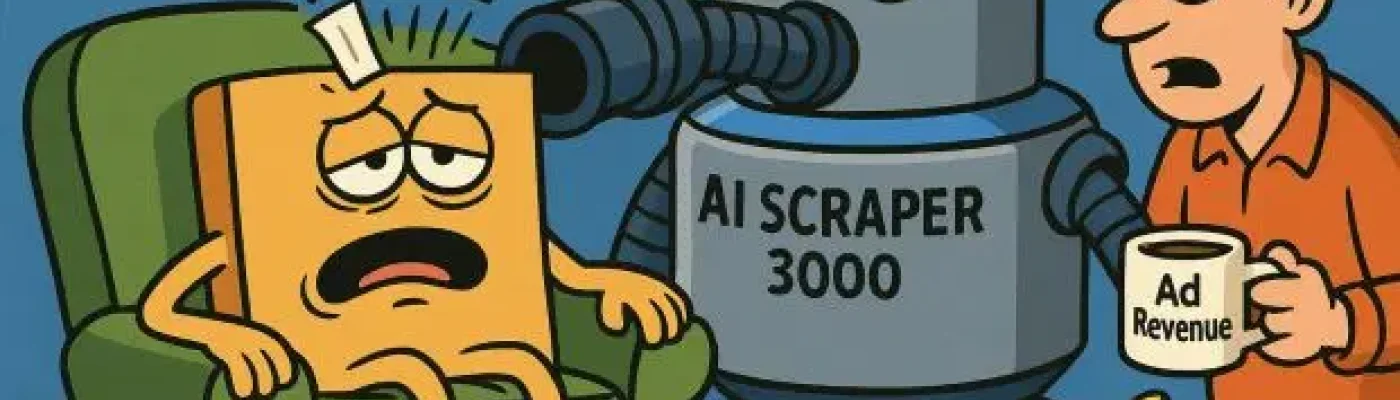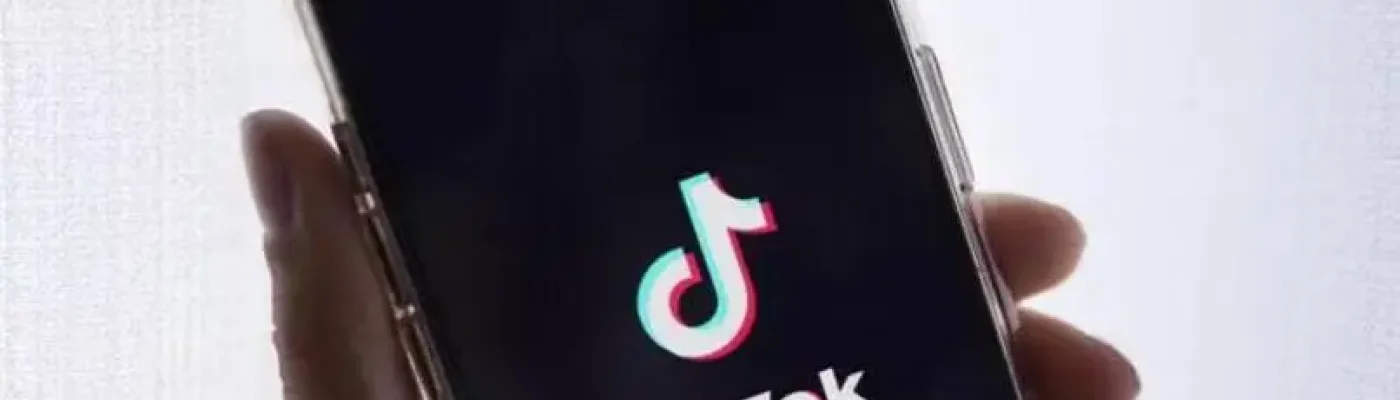Pillole
YouTube sta modificanda le sue strategie pubblicitarie e l'intelligenza artificiale è al centro di questa evoluzione.
Stando alle indiscrezioni, la piattaforma sta sperimentando un sistema basato sull'IA per inserire annunci nei momenti in cui gli utenti sono più propensi a notarli, spesso durante le pause naturali dei video. L'obiettivo è chiaro: massimizzare l'impatto delle pubblicità, anche se un approccio come questo ha l'aria di essere essere un po' troppo invasivo.
L'IA analizza il contenuto dei video per identificare i punti in cui l'attenzione dell'utente è al massimo, come la fine di una scena intensa o un momento di silenzio. Questi istanti, che l'algoritmo considera ideali, diventano il bersaglio perfetto per gli annunci.
Se da un lato questo può (almeno inizialmente) aumentare l'efficacia delle campagne pubblicitarie, dall'altro rischia di interrompere l'esperienza di visione in modo più evidente, suscitando frustrazione negli spettatori.
Newsletter N. 205 - 11 maggio 2025
Numero centrato soprattuto su AI, lavoratori e rapporti di potere
Dopo l’ondata di attenzione e infatuazione mediatica che ha accompagnato il lancio di ChatGPT e di molti altri strumenti di intelligenza artificiale generativa, dopo che per molti mesi si è parlato di vantaggi per la produttività, o di sostituzione del lavoro (soprattutto delle mansioni noiose e ripetitive) con l’AI, siamo arrivati a un punto dove si intravedono più che altro le prime sostituzioni di lavoratori. E ciò sebbene la promessa crescita di produttività lasci ancora molto a desiderare (non parliamo della sostituzione di ruoli).
Mentre gli stessi lavoratori del settore tech (un’elite che per anni ha viaggiato in prima classe anche nelle peggiori fluttuazioni del mercato del lavoro) si sono resi conto di trovarsi in una situazione piuttosto scomoda: più licenziabili, da un lato, e più esposti ai dilemmi etici di lavorare per aziende che hanno abbandonato precedenti remore per contratti di tipo militare, dall’altro.
Partiamo proprio dalla guerra.
Una parte di dipendenti di Google DeepMind (l’unità di Alphabet che lavora sull’intelligenza artificiale e tra le altre cose ha rilasciato Gemini, la famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni) stanno cercando di sindacalizzarsi per contestare la decisione dell'azienda di vendere le sue tecnologie ai militari, e a gruppi legati al governo israeliano.
...
Il chatbot era velocissimo, ma impersonale e impreciso.
Nella corsa frenetica a sostituire i dipendenti umani con la IA che sembra coinvolgere ogni azienda, si è verificata una piccola inversione di tendenza.
Klarna, l'azienda svedese di servizi finanziari specializzata in pagamenti rateizzati, dopo aver sostituito 700 dipendenti con un chatbot AI nel 2024, ora sta tornando ad assumere personale umano per il servizio clienti.
La decisione arriva dopo che un sondaggio interno ha rivelato che soltanto un progetto AI su 4 ha portato un ritorno sull'investimento atteso. Il sondaggio ha evidenziato i limiti dell'automazione in un settore che, a causa dell'interazione con i clienti, non richiede soltanto efficienza ma empatia e flessibilità.
Il proliferare delle intelligenze artificiale non farebbe altro che danneggiare i creatori di contenuti e i siti indipendenti.
Matthew Prince, CEO di Cloudflare (una delle CDN più grandi al mondo), ha lanciato un allarme sul futuro del web durante un'intervista al Council on Foreign Relations: l'intelligenza artificiale starebbe distruggendo il modello di business che ha sostenuto il web per oltre 15 anni.
«L'AI cambierà radicalmente il modello di business del web» ha affermato. «Negli ultimi 15 anni, tutto è stato guidato dalla ricerca online» ma ora le cose stanno cambiando: se un tempo la ricerca su Google portava traffico ai siti tramite i famosi «10 link blu», oggi quella stessa ricerca è fatta per tenere gli utenti sulla piattaforma, fornendo risposte e contenuti tramite la IA.
Dieci anni fa, per ogni due pagine indicizzate, Google rimandava un visitatore al sito; ora, secondo Prince, servono sei pagine per un solo visitatore, con un calo del 200% nel valore restituito ai creatori di contenuti.
Dal governo Usa, un'altra perla targata Mike Waltz: scoperto l'utilizzo di un'applicazione di messaggistica "fork" di Signal che, a differenza dell'originale, memorizza tutte le conversazioni in un archivio "sicuro", accessibile a... tutto il mondo. A sviluppare questo Signal pezzotto, la TeleMessage, una ditta israeliana legata all'IDF.
Facciamo una parentesi nel mondo del trasporto pubblico, guardando più nel dettaglio la notizia relativa all'incremento di produttività: stagnazione della busta paga e utilizzo dei bonus come strumento per erodere i diritti più basilari, a partire da malattia e infortuni.
Torniamo all'informatica, con la sezione delle notiziole:
- progetti di software libero cercano di limitare l'impatto negativo dell'invio di segnalazioni da parte di sistemi basati su LLM
- Meta torna a ricercare l'integrazione, sui suoi occhiali dotati di telecamere, di sistemi di intelligenza artificiale che vi ricordano come si chiama la persona che avete davanti
- una ricerca sulle possibilità di persuasione degli LLM viene condotta su Reddit ignorando le regole della comunità e con discutibile attenzione all'etica, in nome del bisogno di conoscenza
E non dimenticate: a fine mese c'è Hackmeeting!
Il 9 maggio 2025, il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha annunciato un accordo storico con Google, che pagherà un maxi risarcimento di 1,375 miliardi di dollari per chiudere due cause legali intentate nel 2022 e riguardanti gravi violazioni della privacy dei consumatori.
Secondo le accuse, il colosso tecnologico di Mountain View avrebbe violato la privacy degli utenti texani senza il loro consenso esplicito, e in particolare avrebbe:
- raccolto dati biometrici, come impronte vocali e geometria facciale, attraverso servizi come Google Photos e Google Assistant
- tracciato la posizione degli utenti anche quando la funzione di geolocalizzazione era disattivata
- pubblicizzato in modo ingannevole le funzionalità della modalità “Incognito” come strumento di navigazione privata, mentre in realtà continuava a raccogliere dati sulle attività online degli utenti
È passato da pochi giorni il trentaduesimo anniversario della nascita formale del Web, ossia di Internet come la conosciamo oggi. Rispetto all’idea originale, però, sono cambiate tante cose, non tutte per il meglio.
Questa è la storia di come è nato il Web, di cosa è andato storto e di come rimediare, con una lista di “No” da usare come strumento correttivo per ricordare a chi progetta siti, e a noi che li usiamo, quali sono i princìpi ispiratori di un servizio straordinario come l’Internet multimediale che ci avvolge e circonda oggi, e a volte ci soffoca un po’ troppo con il suo abbraccio commerciale.
[...]
Oggi siamo abituati a un’Internet commerciale, ma va ricordato che inizialmente Internet era un servizio dedicato alla comunicazione tra membri di istituzioni accademiche, basato su standard aperti, pensato per abbattere le barriere e le incompatibilità fra i computer e i sistemi operativi differenti e facilitare la condivisione del sapere.
Adesso, invece, le barriere vengono costruite appositamente: per esempio, invece della mail, che è aperta a tutti, non è monopolio di nessuno e funziona senza obbligare nessuno a installare un unico, specifico programma, si usano sempre di più i sistemi di messaggistica commerciali, come per esempio WhatsApp, che appartengono a una singola azienda, funzionano soltanto con l’app gestita e aggiornata da quell’azienda e sono incompatibili tra loro.
Ascolta il podcast o leggi il testo sul sito di Paolo Attivissimo
Sarà obbligatoria da giugno, e conterrà informazioni relative alla durata della batteria, alla resistenza a graffi o cadute e al grado di riparabilità
La Commissione Europea ha presentato la nuova etichetta che dovrà essere applicata sulle confezioni degli smartphone e dei tablet venduti all’interno dell’Unione dal prossimo 20 giugno.
L’etichetta ha uno stile simile a quelle già previste per elettrodomestici, come televisori e frigoriferi; conterrà una classificazione dell’efficienza energetica dei prodotti con un punteggio che va da A (il livello più alto) a G (quello più basso), e informazioni relative ad altri aspetti: la durata della batteria, la reperibilità dei pezzi di ricambio, la resistenza in caso di cadute, graffi e contatto con l’acqua e la facilità di riparazione in caso di guasti.
La prima metà della trasmissione è dedicata al trasporto "pubblico" a Roma, al tema della sua privatizzazione e degli effetti concreti che questo causa: dai "normali" autobus che non passano, alla più sofisticata mancanza di interoperabilità con i sistemi informativi dell'Atac. Facciamo qualche considerazione sui meccanismi di privatizzazione e sulla tattica degli "spezzettamenti".
La seconda metà è invece dedicata alla notizia del recente blackout in Spagna, e all'accusa che le rinnovabili siano la causa. Cerchiamo di distillare la parte di verità contenuta in questa informazione, contestualizzandola però con delle spiegazioni su come funziona, a grandi linee, la rete elettrica e con uno sguardo anche all'importante precedente del blackout del 2003 in Italia.
La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina.
L’accusa dell’autorità è di aver trasferito illecitamente i dati degli utenti europei in Cina, aumentando per altro le tensioni e lo scetticismo (soprattutto dei legislatori occidentali) nei confronti di Bytedance, l’azienda di Pechino proprietaria del social network.
L’importo della multa è superiore alle indiscrezioni che erano trapelate a inizio mese ed è la terza sanzione più alta di sempre, dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi).