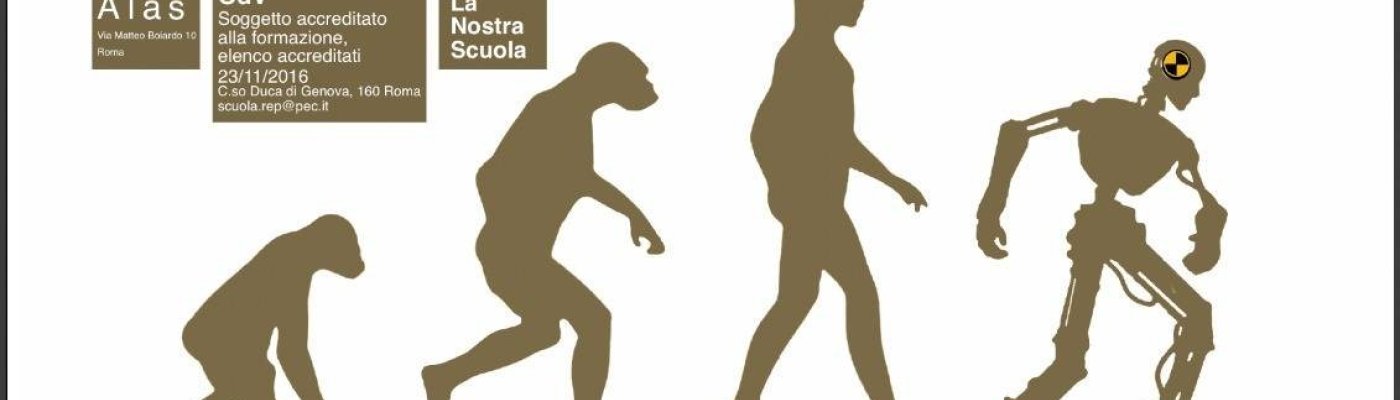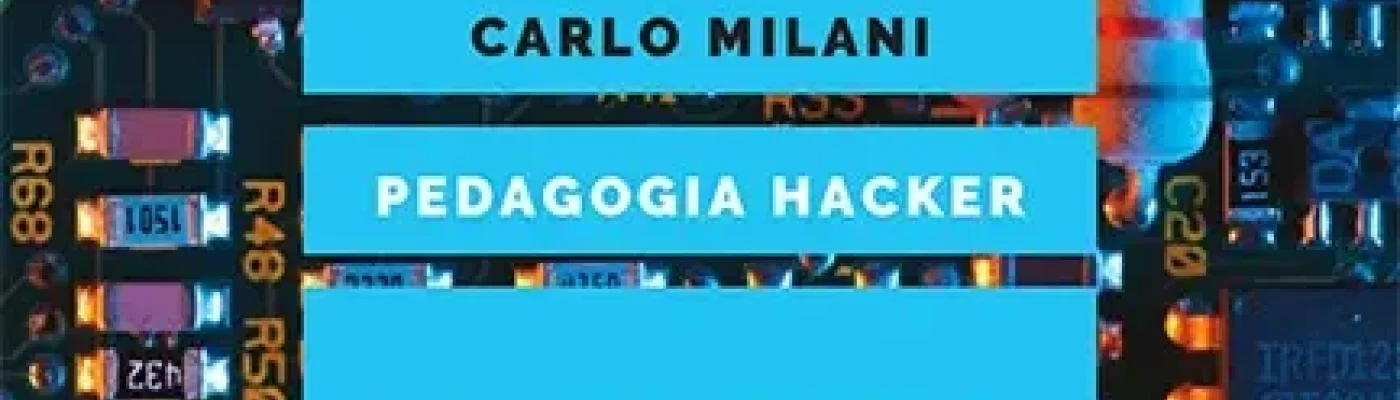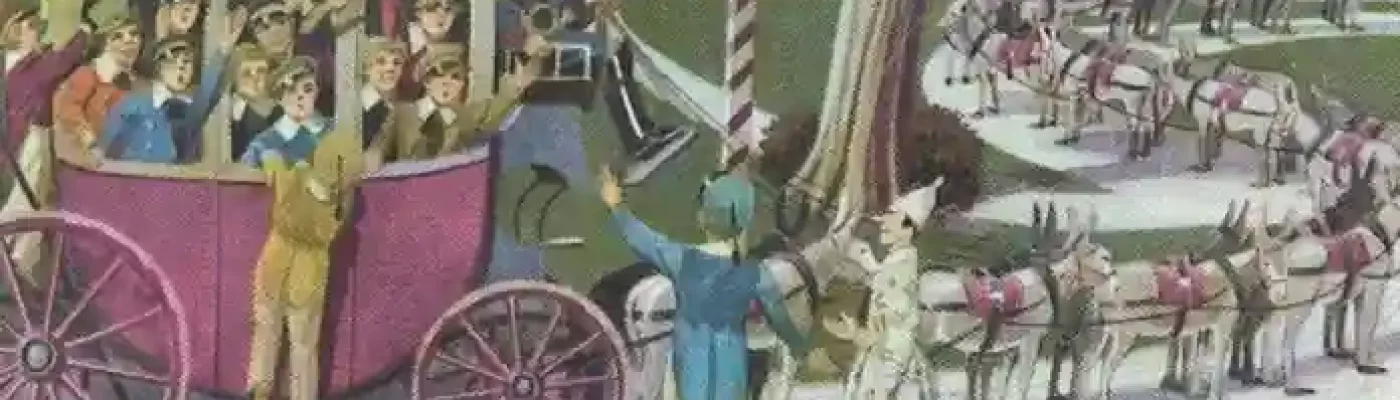Pillole
Martedì 25 febbraio via Stamira, 5 Roma
Convegno di aggiornamento / formazione gratuito per il personale della scuola in presenza (on line solo per i non residenti a roma)
Presso la Sala Convegni di Libera, via Stamira 5.
metro B Bologna Tiburtina
Dalle ore 8 alle 14 Relazioni ed interventi di:
-
Daniela Tafani
(docente di Filosofia Politica, UniPISA)
Libera Transizione digitale: verso dove? Edtech, monopoli e narrazioni -
Maria Chiara Pievatolo
(docente di Filosofia Politica, UniPISA) Di dati e di despoti: la scuola al tempo della transizione tecnofeudale -
Renata Puleo
(maestra, ex dirigente scolastica) INVALSI fra pubblico e privato: come l'istituto usa i dati dei nostri studenti -
Alessandro Zammarelli
(psicoterapeuta) La scuola, la relazione, il digitale -
Stefano Borroni Barale
(docente CUB SUR / Ricercatore Circex.org) Costruire alternative al digitale autoritario -
Ferdinando Alliata
(dottore in Consulenza del lavoro, Cobas Scuola Palermo) Tempi moderni. La digitalizzazione del lavoro di docenti e ATA
Per informazioni: alas.convegno25febbraio@gmail.com; tel. 3274307767
Prosegue la carovana CUB-COBAS per parlare della transizione digitale nella scuola. Dopo Catania, Palermo, Terni, Siena, Grosseto, la carovana toccherà altre città italiane. In programma ci sono Ancona, Cagliari, Milano, Roma, Torino, e molte altre.
Ecco le prossime date. (le date e le informazioni sono in aggiornamento)
- 25 febbraio: seminario "La scuola nella transizione digitale" a Roma
dalle ore 8,30 alle 17 presso la sala convegni di Libera a via Stamira. - 10 o 11 Marzo: seminario a Torino "La scuola nella transizione digitale"
- 17 Marzo: seminario "La scuola nella transizione digitale" ad Ancona
- 25 Marzo: seminario a Cagliari "La scuola nella transizione digitale"
La carovana vuole essere un momento di riflessione e un passo concreto verso una scuola più consapevole e inclusiva, capace di affrontare la trasformazione digitale senza perdere di vista la sua missione educativa e sociale.
Molti sono gli interventi che si succederanno nelle varie tappe della carovana, tra gli altri citiamo, Daniela Tafani, (docente di Filosofia Politica, UniPisa) e Stefano Borroni Barale (docente, CUB/SUR, CIRCE) che saranno affiancart di volta in volta da altre persone e docenti.
La partecipazione è gratuita e prevede l'esonero dal servizio ai sensi del CCNL (art.36) con rilascio del relativo attestato di partecipazione da presentare a scuola.
Torna per vedere gli aggiornamenti...
Fahrenheit, trasmissione di Rai Radio 3, ha intervistato Davide Fant autore con Carlo Milani del libro Pedagogia Hacker.
Un libro per educatori, educatrici, insegnanti, psicologi, tecnici, artisti, ma anche per chiunque sia alla ricerca di pratiche che ci portino a essere soggetti più attivi e soprattutto più consapevoli degli effetti che la tecnologia ha su di noi.
"Con il libro che avete tra le mani vogliamo rispondere all’urgenza di un’educazione sui temi del digitale che ponga al centro le relazioni fra persone e tecnologie. Relazioni ambivalenti che sfociano spesso in vissuti di sofferenza, di euforia a cui seguono cocenti delusioni, di esaltazione spasmodica ed emozioni violente; da questo disagio della tecnica vogliamo muovere per aprire spazi di immaginazione, ri-creazione e liberazione."
Ascolta l'audio dell'intervista
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Veneto , in collaborazione con gli Uffici Ambiti Territoriali (UU.AA.TT.), ha recentemente pubblicato quanto è stato studiato e proposto dal Gruppo di lavoro regionale sull’Educazione alla Legalità. Questo gruppo ha prodotto un documento dettagliato che illustra come adottare il Software Libero nelle scuole.
Il gruppo di lavoro, composto da circa cento docenti delle scuole della Regione Veneto, ha organizzato quattro incontri formativi e informativi da remoto grazie al coordinamento delle referenti di Legalità, Politiche Giovanili e Partecipazione degli Uffici Ambiti Territoriali di Verona e Vicenza.
Non dobbiamo dare lo smartphone per acquisito e limitarci a discuterne l’uso. Dovremmo anche mettere in discussione come è fatto lo smartphone, a tutti i livelli
Da molti mesi si parla con particolare intensità di smartphone e adolescenti. Era qualche anno che se ne discuteva, dando anche vita alle prime iniziative, ma è solo nel 2024 che l’argomento dell’impatto dello smartphone sul benessere psicologico e sulle prestazioni scolastiche dei più giovani è entrato con forza nel dibattito pubblico, conquistando spazio nei media e diventando oggetto di iniziative politiche. In particolare, sono due le proposte intorno alle quali si polarizzano l’attenzione e le proposte: se proibirne o meno l’uso a scuola (come è stato deciso di recente in Italia e in altre Paesi, europei e non) e se proibire o meno del tutto lo smartphone sotto una certa età (per esempio, sotto i 16 anni).
Il modello, insomma, è quello delle sigarette...
Leggi l'articolo di Juan Carlos De Martin sul sito de "Il Manifesto"
Un articolo scientifico di daniela tafani, prezioso, ricco di spunti di riflessioni e di verità tanto evidenti quanto nascoste.
Il testo demistifica le "credenze" relative alla presunta intelligenza dei software probabilistici e ristabilisce dei punti fermi sulla non neutralità del software, anche quando si tratta di cosidetta Intelligenza Artificiale.
L'articolo dimostra perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella scuola e nelle univeristà sia un problema per i processi di apprendimento e insegnamento. Tuttavia si tratta di una tendenza già presente: la trasformazione dell'insegnamento in addestramento degli studenti per andare incontro alle esigenze del mondo aziendale.
Indice
- Macchine per scrivere frasi probabili
- La bolla dell’“intelligenza artificiale generativa”
- Il valore dell’istruzione: le aziende e le narrazioni Edtech
3.a. L’idea che la sorveglianza sia una forma di cura
3.b. Il mito della personalizzazione dell’apprendimento
3.c. Il soluzionismo tecnologico
3.d. L’idea della neutralità delle piattaforme “educative” - Girelli, stampelle e ciuchini: gli omini di burro nei sistemi neoliberali
Nota bibliografica
Giovedì 31 ottobre a Roma, in Via della Dogana Vecchia 5, alle ore 18:00, il seminario promosso dalla Scuola critica del digitale del CRS. Ne parlano Maurizio (Graffio) Mazzoneschi, Agnese Trocchi, Stefano Borroni Barale, Carlo Milani. Coordina Giulio De Petra.
Nelle scuole e nei contesti educativi si (stra)parla di tecnologia esaltando quelle abilità e competenze che i ragazzi devono possedere affinché si spalanchino loro le porte del futuro (lavorativo ovviamente), oppure se ne parla come risorsa che può rendere più efficace ed efficiente la trasmissione e l’accumulo di sapere e di abilità. Ovviamente non manca anche la prevenzione dai rischi, ma in un approccio declinato quasi sempre come lotta all’«usare male» i dispositivi: con loro possiamo perdere tempo, fare brutte cose o incontrare brutte persone che fanno fare brutte cose. In ogni caso lo strumento è sempre percepito come neutro (dipende da come lo usi…) e l’uomo è sempre chiamato a dominare, anzitutto la macchina, ottimizzando il guadagno che gli può portare, ma anche se stesso, tenendo bene a mente che qualsiasi deviazione negativa avviene solo per colpa sua, perché non si è impegnato abbastanza (è scontato come in questo paradigma gli adolescenti non possano che uscirne male…).
Consapevole di questo contesto, e non rassegnato alla sua inevitabilità, CIRCE (Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche), nell’ambito delle azioni del PNRR, sta realizzando per l’anno scolastico 2024/2025, corsi gratuiti di Pedagogia Hacker rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie.
I corsi si dividono in tre livelli: il primo, intitolato “Non dipende (solo) da te”, ha l’obiettivo di rendere possibile un approccio consapevole alla rete e di scoprire i meccanismi di manipolazione cognitiva delle piattaforme interconnesse di massa, con uno specifico approfondimento su come gli strumenti di formazione a distanza influenzano il lavoro educativo.
Nel secondo, intitolato “Internet e strumenti conviviali”, si ragiona su come fare “riduzione del danno” nel rapporto con lo strumento elettronico facendo fronte ai problemi concreti di organizzazione, collaborazione, partecipazione con strumenti digitali, e si indaga l’impatto delle tecnologie digitali, AI inclusa, sulle dinamiche organizzative e didattiche.
Nel terzo, “Costruzione di attività didattiche”, si sperimentano buone pratiche di insegnamento e si ragiona su quali dati sono utili alla scoperta e all’approfondimento della conoscenza e di quali possiamo fare a meno.
Nel corso dell’incontro si presenteranno e discuteranno non solo le motivazioni, i contenuti e le caratteristiche dell’intero progetto, ma anche i risultati ottenuti nelle prime esperienza formative realizzate.
Il punto originale da cui partire, che anima tutto il progetto, è l’attitudine hacker: quella curiosità, immaginazione, desiderio di gioco trasformativo di cui sono esperti i bambini, da cui non possiamo che imparare, da riscoprire e coltivare insieme.
Per chi, pur interessato, non potrà partecipare di persona è prevista la possibilità di seguire l’incontro collegandosi tramite il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81948891898
Maggiori informazioni sul sito del Centro per la Riforma dello Stato.
Durante "L'ora di buco", la trasmissione di Radio Onda Rossa in cui lavoratori e lavoratrici della scuola parlano di scuola, sono stati presentati i corsi di Pedagogia Hacker su misura per docenti delle scuole primarie e secondarie. I corsi, anche per l'anno scolastico 2024/2025, sono finanziati dal PNRR. Sono gratuiti per le insegnanti e gli insegnati.
Possono partecipare ai corsi i docenti delle scuole secondarie o primarie, sia di ruolo che precari/e. Per ogni corso seguito verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Durante la corrispondenza si è paralto anche di cosa è il metodo della Pedagogia Hacker.
Ascolta l'audio sul sito di Radio Onda Rossa
Si tratta di 3 corsi:
- Non dipende (solo) da te (corso base)
- Internet e strumenti conviviali (corso intermedio)
- Costruzione di attività didattiche (corso avanzato)
Tutte le informazioni su edizizoni, date, orari, modalità di iscrizioni, si trovano nell'apposita pagina sul sito web di CIRCE.
Nell'ambito delle azioni del PNRR anche per l'anno scolastico 2024/2025 C.I.R.C.E. ha organizzato dei corsi di Pedagogia Hacker su misura per docenti delle scuole primarie e secondarie. Scopri i 3 cicli: date, orari e contenuti.
Ogni corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie o primarie, sia di ruolo che precari/e ed è gratuito. Puoi scegliere di partecipare a uno dei corsi o a tutti e tre. Il primo corso è propedeutico ai successivi. Per ogni corso seguito verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Segui questo link per vedere la registrazione della presentazione
Sul sito di CIRCE puoi leggere titoli, orari e panoramica dei corsi
Nell'ambito delle azioni del PNRR anche per l'anno scolastico 2024/2025 abbiamo organizzato dei corsi di Pedagogia Hacker su misura per docenti delle scuole primarie e secondarie. Scopri i 3 cicli: date, orari e contenuti.
Ogni corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie o primarie, sia di ruolo che precari/e ed è gratuito. Puoi scegliere di partecipare a uno dei corsi o a tutti e tre. Il primo corso è propedeutico ai successivi. Per ogni corso seguito verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Webinar di presentazione dei corsi
Il 24 settembre 2024 alle 19.00 si terrà una breve presentazione online dei corsi e del programma. Potrete farci tutte le domande del caso e capire se il corso fa per voi.
I corsi
- Non dipende (solo) da te (corso base)
- Internet e strumenti conviviali (corso intermedio)
- Costruzione di attività didattiche (corso avanzato)